Le arti ed i mestieri in cascina

 “Parona tèra böna”, 2007
“Parona tèra böna”, 2007
Dopo la seconda guerra mondiale, con la meccanizzazione del lavoro, nelle campagne è iniziato il declino della cascina. Oggi molte sembrano fantasmi di un passato lontanissimo, ma alcune realtà resistono all’ingiuria del tempo e all’indifferenza della civiltà industriale. E’ verso queste unità che ci indirizziamo per riscoprire ciò che rimane delle nostre radici comuni.
In quelle radici che rappresentano inizi comuni ed ancor diffusi, di mestieri che affondano le loro origini in epoche remote. Nelle corti di Lombardia, tra le principali figure che spiccano all’interno di una ben sperimentata organizzazione, possono essere evidenziati questi “artisti minori”, ma il cui apporto fu fondamentale per il progresso agricolo della regione.
Il casaro
Il caseificio era il luogo dove il frutto della natura e del lavoro veniva valorizzato in un prodotto atto ad essere collocato sul mercato per il profitto dell’imprenditore e per quel poco di reddito che finiva come salario nelle tasche dei lavoratori.
Tra fumo ed umidità, tra “piate” (grossi recipienti a larghe tese) e “spanarole” (piatti di rame o di legno per raccogliere la panna), tra “sangule” (zangole per il burro) e “tassel” (secchielli per assaggiare il formaggio) lavoravano gli uomini dei caseificio guidati dal “cacè”, detto anche “cap cacè”.
L’importanza del suo lavoro e delle sue responsabilità gli davano una posizione di particolare prestigio e rispetto tra tutti i dipendenti dell’azienda. Intanto normalmente abitava o presso il caseificio o in una casa vicina alla casa padronale, comunque in una posizione ben distinta dalle altre abitazioni.
Il mungitore

 “Parona tèra böna”, 2007
“Parona tèra böna”, 2007
Il porcaro
Può sembrare curioso che un posto di lavoro come la “cacèra”, così importante, avesse vicinissimo il porcile, e può sembrare ancor più curioso che il “purchè” (porcaro) lavorasse talvolta nel caseificio. Il fatto è che, dato che i maiali erano i consumatori degli scarti della produzione del formaggio, il “cap cacà” era anche responsabile della porcilaia. dopo di lui veniva il “purchè” aiutato di solito da un ragazzotto, il “nimalàt”.
Il “purchè” era quello che lavorava sepre con i maiali. Le sue attenzioni erano dedicate in particolar ealle scrofe ed ai lattonzoli, alla riproduzione ed allo svezzamento. Dopo queste fasi delicate seguiva lo svilupo dei suini ripartendoli nei vari “stabiol” (baste) a seconda dell’età e della grossezza, e accudedo loro.
Il falegname
In cascina il falegname veniva chiamato “marengòn” o “lignamè”. Il suo compito era di metter mano a tutto ciò che era di legno, agli attrezzi da lavoro, in particolare fabbricava i carri. Molti dei suoi lavori erano in stretto collegamento con il fabbro. In cascina aveva un suo posto dove lavorare, e dove tenere il suo bancone, la pialla, la sega, il martello, i chiodi ma, difficilmente, il falegname viveva in cascina; era una figura un po’ esterna all’azienda, forse un po’ più libera.
Il fabbro ferraio

 “Parona tèra böna”, 2007
“Parona tèra böna”, 2007
Il mugnaio
Il mugnaio (“murnè”) non era un dipendente della cascina, ma svolgeva un tipo di lavoro che lo metteva in stretto contatto con questa. Tranne che nelle grandi aziende, che provvedevano direttamente alla macinazione, il mugnaio serviva tutti gli agricoltori e le famiglie dei salariati; passava con il suo carretto ogni due o tre giorni per le case dei salariati a prelevare il sacco di grano da macinare o per consegnare la farina o il riso già lavorati al mulino. La sua attività richiedeva un insieme di conoscenze tecniche che coinvolgevano l’idraulica, la meccanica e la falegnameria, un patrimonio di esperienza e di tecnica di indiscusso valore.
Per sé tratteneva la percentuale del macinato che gli spettava per la macinatura fatta. Il mugnaio non godeva di un particolare prestigio nell’ambito della scala sociale, molto probabilmente per la fama che lo accompagnava: infatti era spesso sospettato di trattenere più della quota fissata per la macinazione.
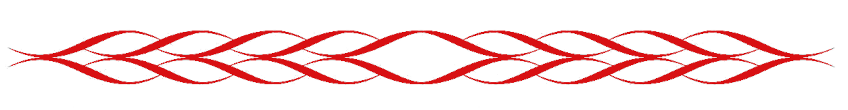
Parte del materiale di questa pagina è stato estratto dalla pubblicazione “Invito a Corte - Tradizioni, Arte, Cultura, Folklore, Prodotti tipici, Enogastronomia nelle Corti rurali Lombarde” (ed. Regione Lombardia).